Salve! Ottimi passaggi. Semplici da apprendere e lineari. Un ottimo lavoro infine.
Sin dall'inizio della mia lettura di questo topic ho pensato di attribuirne un cenno storico molto importante nel campo dell'aviazione, che riguarda soprattutto l'importante sviluppo nella tecnologia meccanica dei primi velivoli.
Parlerò dei primi motori a scoppio fino ad arrivare ai modori radiali "a stella" costituiti fino a 18 cilindri, poi parlerò dei vantaggi e degli svantaggi nell'uso di queste macchine. Parlerò dello sviluppo e delle applicazioni fattesi allo straordinario motore radiale a "doppia stella" e delle ultimazioni statunitensi che hanno fatto un enorme progresso fino ad arrivare ai motori radiali a quattro stelle da sette cilindri con il totale di 28 cilindri.
Il lavoro che farò in seguito non sarà un semplice banale lavoro di copiatura, si tratta di un lavoro che ho studiato in precedenza e che ora scrivo qui utilizzando alcune informazioni prelevate dai miei libri o dalle mie fonti di informazioni.
Ogni errore della mia discussione, pertanto, é da ascriversi solo ed esclusivamente al sottoscritto.
- 1.0 I PROGRESSI DELL'AVIAZIONE
1.1 PROPULSORI AERONAUTICI: I MOTORI RADIALI
Nella Seconda Guerra Mondiale i motori maggiormente utilizzati dall'aviazione erano quelli a scoppio. Gli aerei più grandi, come i bombardieri, disponevano di grossi motori a cilindri radiali molto potenti.
Il motore montato nel Dicembre del 1903 sul Flynger dei fratelli Wright, l'aereo che diede il via alla storia dell'aviazione, era un motore a scoppio endotermico dotato di quattro cilindri, al cui interno si verificava una rapida combustione ("scoppio") che spingeva verso il basso i pistoni.
Questi ultimi, collegati attraverso le bielle all'albero motore, generavano un movimento rotatorio che veniva sfruttato per mettere in movimento, attraverso una trasmissione, l'elica aerea.
Il motore a scoppio dell'aereo dei fratelli Wright era semplice e primitivo (non disponeva neppure di acceleratore per variare il regime di rotazione) ma tuttavia sviluppava 12CV, una potenza sufficiente per permettere al Flyer di sostenersi in volo per circa 200 metri.
1.2
I MOTORI A SCOPPIO
L'impresa dei fratelli Wright aveva dimostrato che il motore a scoppio era il solo tipo di propulsore in grado di permettere il volo delle macchine "più pesanti dell'aria", come venivano definiti a quei tempi gli aeroplani. Nel corso degli anni i motori a pistoni conobbero un grande sviluppo, tanto nella forma quanto nel funzionamento. I primi motori si basavano sul ciclo Otto (dal nome dell'ingegnere tedesco Nicolaus August Otto, inventore del motore a combustione interna a quattro tempi), un sistema utilizzato ancora oggi.
Si testarono anche motori a Diesel, alimentati da gasolio o da olio pesante. Il raffreddamento era di due tipi: ad aria o ad acqua (o altro liquido).
I motori potevano avere cilindri in linea o disposti a stella (i cosiddetti radiali). Entrambi vennero ampiamente utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale degli schieramenti contrapposti. La funzione dei motori era quella di muovere una o più eliche a loro volta, girando, producevano la spinta traente di cui aveva bisogno l'aereo.
Gli aereoplani che presero parte alla Seconda Guerra Mondiale , e specialmente i bombardieri, furono progettati in modo da poter utilizzare tipi diversi di motori. In questo modo si potevano realizzare senza problemi versioni dello stesso aereo con un duverso apparato motore pensato appositamente per impieghi specifici o che richiedesse prestazioni particolari. Furono infatti molto numerosi i bombardieri che durante la guerra montarono sia motori in linea sia motori radiali.
1.3
I MOTORI RADIALI
I primi motori radiali (detti anche stellari) utilizzati dall'aviazione aveva tre cilindri a raggiera; più tardi diventarono cinque e poi sette sistemati "a stella". Questi cilindri erano disposti radialmente in piano; al centro, in posizione perpendicolare, c'era l'albero motore sul quale prolungamento si trovava l'asse dell'elica. Con il progredire della tecnica furono realizzati motori radiali dotati di turbocompressore o "a doppia stella" con due blocchi di cilindri accoppiati uno davanti all'altro, in grado di offrire una potenza davvero considerevole. Quasi tutti i motori radiali erano raffreddati ad aria, anche se non mancarono riusciti esempi di motori radiali che usavano un complesso sistema di raffreddamento a liquido. Durante la Seconda Guerra Mondiale, furono impiegati su molti aerei da caccia e su alcuni bombardieri i motori rotativi. Simili per aspetto ai radiali, erano in realtà strutturamente diversi: avevano, infatti, la caratteristica di montare l'elica in modo solidale al blocco dei cilindri, che ruotava insieme con essa. Semplici e relativamente potenti, questi motori risultavano però poco affidabili e avevano un elevatissimo consumo di carburante e di olio. Furono generalmente abbandonati dopo il 1918.
1.4
VANTAGGI E SVANTAGGI
Il motore radiale, raffreddato ad aria tramite alette che, applicate a ciascun cilindro, disperdevano calore accumulato, era più pesante di quello refrigerato ad acqua ma diventava più leggero se si teneva conto di tutti gli elementi accessori necessari al sistema liquido (refrigerante, radiatori, conduttore) che il motore radiale non aveva. Più compatto, meno vulnerabile in combattimento, più resistente agli sbalzi di temperatura, il motore radiale si presentava come il propulsore ideale per i velivoli plurimotore che non richiedevano un'aerodinamica esasperata. Il solo difetto dei motori radiali, infatti, era la maggiore sezione frontale rispetto a quelli con i cilindri in linea o a V, con conseguente penalizzazione in termini capacità di penetrazione nell'aria.
La forma circolare e la collocazione frontale rendevano piuttosto complicata la carenatura del motore radiale. Nel periodo tra le due guerre venne trovata la soluzione di dotare i motori di un anello che coinvolgesse l'aria per il raffreddamento della stella di cilindri. I più usati furono gli anelli Townend, (dal nome del suo inventore), e le carenature statunitensi NACA (National Advisory Committee for Aeronautics).
1.5
LO SVILUPPO
Gli aumenti di cilindrata mirati alla ricerca di maggior potenza portarono a motori con diametri sempre maggiori e, di conseguenza, con più ampia superficie frontale. Si pensò allora di ridurre il volume del singolo cilindro aumentandone il numero; si arrivò a montarne anche nove e, nel corso degli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale, esistevano entrambe le configurazioni: da sette e da nove cilindri. Poco prima che scoppiasse il conflitto fecero la loro comparsa i motori con doppia stessa, ai quali abbiamo già accennato. I cilindri del secondo blocco erano sistemati negli spazi esistenti tra i cilindri del primo e questo migliorava il raffreddamento. Il risultato era un motore da 14 cilindri con il doppio della potenza, meno del doppio del peso e una buona compattezza. Il passo successivo fu un motore da 18 cilindri formato da due stelle da nove.
1.6
LE APPLICAZIONI
Prima della Seconda Guerra Mondiale, il motore radiale era molto diffuso negli Stati Uniti, mentre risultava quasi assente in Germania; Italia, Gran Bretagna e Francia, utilizzavano sia motori in linea sia radiali.
La maggior parte dei grandi bombardieri quadrimotori montò i radiali: i Boeing B-17 contavano sui Wright Ciclone E-1820 da nove cilindri ciascuno da 1.200 CV, mentre i B-24 disponevano dei P&W Twin Wasp R-1830 da 14 cilindri. I b-29 erano equipaggiati con quattro Wright Ciclone R-3350 da 18 cilindri e 2.200 CV.
Il bombardiere inglese Short Stirlight aveva i Bristol Hercules da 14 cilindri e 1.650 CV, lo stesso di alcune versioni dell'Handley Page Halifax.
In Germania il motore radiale fu poco utilizzato : inizialmente c'erano il BMW 132 da 1.000 CV sullo Ju 52/3m e sul Fw 200 e il BMW 323 sul Do 24, entrambi da nove cilindri. In seguito il formidabile BMW da 14 cilindri passò da 1.600 CV fino a 2.300, con soli 129 cm di diametro e venne usato sul caccia Fw 190 e anche, tra gli altri, sui bombardieri Jh 88S/T, Ju 188, Ju 228, Ju 290, Ju 390 e Do 217.
In Giappone negli utlimi mesi di guerra i motori erano a doppia stella da 14 o 18 cilindri, con potenze da 2.000 CV.
La Francia impiegò i suoi Gnome-Rhone da 14 cilindri su numerosi bombardieri. Anche la Regia Aeronautica italiana contava su numerosi modelli di motori radiali che installò tanto sui caccia quanto sui bombardieri.
1.7
GLI ULTIMI MODELLI
I mastodontici bombardieri apparsi alla fine della guerra e all'inizio del dopoguerra avevano bisogno di una potenza straordinaria che esigeva motori di cilindrata sempre maggiore. Lo sviluppo tecnico divenne esasperato, tanto che si giunse a realizzare motori radiali con ben quattro stelle di cilindri.
A questo riguardo, il vertice dello sviluppo fu raggiunto con il Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major, un motore turbocompresso con 28 cilindri in quattro stelle da sette.
Il motore, raffreddato ad aria, era in grado di erogare circa 4.000 CV e fu impiegato sui bombardieri B-50 e B-36.
Oltre questo limite non fu possibile andare e i motori radiali vennero ben presto sostituiti da quelli a reazione.
- 1.8 DAL BIPLANO AL MONOPLANO: Una rapida evoluzione
Alla fine degli anni Trenta, grazie ai formidabili progressi della tecnologia, gli aerei militari erano già molto diversi da quelli della Prima Guerra Mondiale e dell'immediato dopoguerra.
1.9
LA PROFONDA RECESSIONE ECONOMICA MONDIALE degli anni Venti e, al tempo stesso, l'esistenza di un considerevole numero di aerei risparmiati dalla Grande Guerra - aerei che venivano venduti a prezzi molto bassi, scoraggiando chi volesse fabbricarne di nuovi - fecero si che tra il 1920 e il 1930 gli sforzi fossero concentrati sulle migliorie ai motori e alla meccanica in generale e non sulla produzione di nuovi velivoli. In questo periodo i progressi dell'aviazione furono straordinari: si può dire che non ci fosse giorno in cui non venisse stabilito un nuovo primato e questo suscitò, ovviamente, l'entusiasmo della gente. Tutto ciò fu di stimolo per la progettazione di aerei con caratteristiche d'avanguardia pronti per affrontare, una volta terminata la depressione economica, le nuove sfide imposte dal progresso.
1.10
ALLA CONQUISTA DEI CIELI
La rapida evoluzione tecnologica riguardò anche, o forse soprattutto, l'aeronautica militare, che ne trasse vantaggi enormi, decisamente superiori alle più rosee aspettative. Incominciò così da parte delle grandi potenze mondiali una vera e propria corsa alla conquista dei cieli.
A inizio anni Trenta non c'era un solo modella di aeroplano che non avesse bisogno di essere migliorato. Tra gli elementi sotto esameci fu innanzi tutto la cellula con la fusoliera.
Fino a quel momento la scelta si era orientata sul biplano a due ali (ovvero quattro semiali), ma ben presto ebbero la meglio i sostenitori del monoplano a un'ala (ovvero due semiali). Stesso discorso per il materiale. Se fino ad allora c'era stata una netta prevalenza del legno, in breve le industrie aeronautiche lo sostituirono con metalli e leghe.
Uno degli elementi più importanti era naturalmente il motore, che i tecnici volevano più potente e, al tempo stesso, più leggero e meno ingombrante.
Con il progressivo aumento della velocità , fu necessario tenere contro dei fattori aerodinamici che influivano da un lato sulla stabilità del velivolo e dall'altro sull'autonomia. Per affrontare questo problema vennero impiantati i primi laboratori di ricerca, con quei tunnel aerodinamici che sarebbero poi diventati noti come "gallerie del vento".
La stessa attenzione fu riservata agli accessoori, alcuni molto importanti, che vennero testati e migliorati in continuazione.
Parallelamente si studiano le possibilità di impiego militare dell'aviazione, valutando quali potessero essere le azioni di guerra più idonee all'impiego degli aerei. Vennero elaborate varie strategie e proprio in quel periodo prese corpo l'idea di creare una terza arma indipendente dell'Esercito e dalla Marina. Una definizione più precisa delle missioni portò inoltre a una maggiore specializzazione degli aerei e, come conseguenza, a differenze strutturali più circostanziate nei diversi tipi di velivoli e, di conseguenza, anche allo studio di armamenti specifici per ciascun tipo di aeroplano.
1.11
IL DISEGNO DELLE ALI
Studi specifici vennero dedicati alle ali, l'elemento che durante il volo genera il sostentamento (o portanza) che tiene in aria il velivolo. Le ali non sono piatte, ma presentato una differenza di curvatura tra la superficie superiore (detta extradosso o semplicemente dosso) e quella inferiore (intradosso o ventre), molto più piana.
Quando raggiungono una determinata velocità , le ali feondono l'aria in modo che una parte vada nella sezione superiore e l'altra in quella inferiore per poi riunirsi nuovamente nella parte posteriore (bordo di uscita). L'aria scorre più rapida nella zona dove l'ala presenta la maggiore curvatura (l'extradosso) e fa sì che in quella zona diminuisca la pressione (come spiega il "principio di Berulli", secondo il quale in un flusso d'aria dove aumenta la velocità diminuisce la pressione), creando una differenza rispetto alla pressione esercitata sull'intradosso sottostante: é in questo modo che si genera il sostentamento dell'aereo e del suo carico.
Quando maggiore é la differenza di curvatura delle ali , e pertanto del suo spessore, tanto maggiori saranno il sostentamento e la resistenza dell'aria. Come nel caso di un qualsiasi automezzo terrestre, tutto si riduce in definitiva a spostare una massa a una certa velocità per mezzo di una determinata potenza. Il problema pratico é quello di disporre di questa potenza e saperla applicare con efficacia.
Ci sono poi anche altri fattori, come per esempio una leggera inclinazione del piano delle ali (chiamato celettamento alare) e la presenza di elettoni che non contribuiscono al sostentamento, ma lo distribuiscono in modo che il velivolo possa compiere le virate.
1.12
LA SCELTA DEI BIPLANI
Nei primi aerei, per assicurare il sostentamento si utilizzavano superfici alari enormi. Viste, però, le difficoltà di costruire ali molto lunghe, fu adottata la soluzione di montarne due paia, o anche di più.
Un bombardiere biplano classico, come per esempio il DH-9A, lungo 9,22 metri, con un'apertura alare di 14 metri e una superficie di 45,22 metri quadri, se fosse stato dotato di un solo paio di ali avrebbe dovuto averle lunghe 28,5 metri, cosa assolutamente impossibile da realizzare con una struttura in legno e con momenti di inerzia ed "effetti torsione" di grande rilievo. Anche se obbligata, la scelta dei biplani tuttavia presentava molti svantaggi, il maggiore dei quali era il gran numero di montanti e cavi che bisognava sistemare tra le ali per assicurare la stabilità . Apparve evidente che prima o poi sarebbe stato inevitabile orientarsi verso i monoplani ma a quel tempo i limiti tecnici dell'aeronautica lo impedivano. Una soluzione intermedia si ebbe con la fabbricazione di "sesquiplani", aerei con un'ala grande e le altre, generalmente quelle inferiori, di lunghezza molto minore. Nei grandi aerei, per i quali la velocità non era l'impiego più importante, l'impiego di spessi profili alari facilitò la costruzione di una struttura interna di una struttura interna sufficientemente resistente per poter fare a meno dei montani esterni, cosa che portò a monoplani con le ali che "sfarfallavano" durante il volo. Nei primi monoplani, l'ala sostenuta da robusti montani, poteva essere situata in cima alla fusoliera (monoplani ad "ala alta"); al centro ("ala media") o in basso ("ala bassa"). Senza considerare le esigenze della fabbricazione, veniva adottata una o l'altra soluzione in funzione della missione a cui l'aereo era destinato. Il velivolo ad "ala alta" permetteva una migliore visione verso il basso e facilitava l'installazione di ripostigli per le bombe; quello ad "ala bassa" consentiva di integrare i longheroni dell'ala nella base della fusoliera e migliorava la difesa dall'alto. L'aereo ad "ala media" garantiva una migliore solidità strutturale.
Questi furono i maggiori problemi generali, comuni alle forze aeronautiche di tutto il Mondo, che riguardarono i bombardieri attivi solo qualche anno dopo nella Seconda Guerra Mondiale.
1.13
IL RAPPORTO PESO-CARBURANTE
Un aeroplano con motori in ottimo stato può sviluppare tutta la sua potenza in determinate condizioni di pressione atmosferica e di temperatura dell'aria (la densità ), ma non sarà ugualmente in grado di alzarsi da terra e volare se supererà un determinato peso.
In particolare i bombardieri, che nelle operazioni belliche devono sempre sostenere un carico considerevole di bombe, con l'obbligo di trasportarle, quasi sempre a grande distanze, é importante che non superino certi limiti. Oltre alle bombe, devono infatti trasportare anche un certo numero di uomini e, soprattutto, una quantità non indifferente di carburante. Una volta considerato il peso dell'aereo vuoto, dell'equipaggiamento, degli uomini dell'equipaggio, dell'armamento e delle munizioni, a questi velivoli resta un margine di capacità di trasporto che deve essere ripartito con grande oculatezza tra bombe e carburante. E' essenziale, pe non correre inutili rischi nel corso dell'operazione, caricare soltanto lo stretto necessario. Quanto più distante sarà l'obiettivo da raggiungere, tanto minore di conseguenza dovrà essere il carico. Questa regola vale non soltanto per i bombardieri ma anche per gli aeroplani da ricognizione e per quelli adibiti al trasporto truppe. Un velivolo troppo carico, oltre a incontrare notevoli difficoltà in fase di decollo, rischia di mettere in sofferenza anche i motori e non raggiungerà l'altitudine prevista.
- 2.0 LA NASCITA DELL'AERONAUTICA MILITARE
2.1 UN'EVOLUZIONE PRODIGIOSA
Dopo 15 anni di vita, l'aviazione dimostrò di essere una delle armi più efficaci di tutti i tempi. Dai grossolani velivoli in legno e tela si passò in poco tempo a costruire aerei in grado di colpire il nemico anche con azioni a lungo raggio. Nacquero così i grandi bombardieri.
2.2
ALLO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE erano passati poco più di 10 anni dal giorno in cui i fratelli Wright avevano effettuato il loro primo volo del 17 Dicembre 1903. Pertanto, anche se i progressi dell'aviazione in quel periodo furono straordinari, gli aeroplani restavano ancora rudimentali. La loro struttura principale era in legno con pochi rinforzi metallici, mentre i posti per l'equipaggiamento erano in vimini e solitamente situati a ridosso dei serbatoi di carburante. Inoltre, questi velivoli erano privi di alettoni e si pilotavano solo ed esclusivamente con operazioni manuali.
Quando i motori di questi primi aeroplani erano al massimo regime, le vibrazioni intensissime scuotevano tutto il velivolo e si aveva l'impressione che da un momento all'altro l'aereo dovesse cadere a pezzi. Cosa che in effetti, in alcuni casi é anche successa. Durante i primi mesi della Grande Guerra la Germania perdette per questo motivo almeno un centinaio di aerei. Nella maggior parte dei casi si verificavano cedimenti della struttura o defaillances del motore. Inoltre, a quell'epoca, gli aeroplani non avevano ancora un impianto frenante. Quando si trovavano al suolo con il motore acceso gli aerei dovevano essere trattenuti dal personale a terra fino a quando, a un preciso segnale del pilota, venivano lasciati liberi e si potevano alzare in volo.
2.3
GLI ATTACCHI DALL'ALTO
I primi aerei avevano una strumentazione di bordo molto primitiva e ridotta all'essenziale: i contagiri del motore, un altimetro, un compasso per l'orientamento e un termometro. Per controllare il carburante, i piloti, sapendo che l'autonomia di volo arrivava al massimo a tre ore, si servivano di un orologio da polso.
Il peggior nemico dei piloti era il freddo. Molti di loro morirono assiderati mentre erano in volo in pieno inverno a una temperatura di 30° sotto zero a 2.000 metri di quota. Questo problema fu risolto soltanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
La velocità media dei primi bombardieri era di 100 K/h e l'altitudine arrivava intorno ai 2.000 metri.
Soltanto pochi aerei davano al pilota la possibilità di controllare la velocità e questo faceva si che molto spesso un mezzo arrivasse troppo forte sulla pista di atterraggio; in questi casi il pilota era costretto a riprendere quota per ritentare la manovra a una velocità inferiore. Nel 1914 non esistevano ancora modelli specifici per missioni di combattimento e neppure un appropriato sistema di puntamento.
I tedeschi utilizzarono aerei come l'Etrich Taube, un velivolo con grandi ali che assomigliava a un piccione e con il quale bombardarono la città di Parigi. In realtà , quelle che vennero scaricate da questo aereo non erano che semplici bombe a mano modificate in maniera rudimentale.
Prendendo spunto dall'esempio tedesco, anche i francesi, durante la Prima Guerra Mondiale, cominciarono a utilizzare i loro aerei con compiti di bombardamento. Oltre alle granate avevano come armi una specie di dardi metallici chiamati "freccette" che, lanciati da una certa altezza, potevano uccidere.
Il principio gli inconvenienti nati dall'utilizzo degli aeroplani a scopi militari fece credere che per bombardare dall'alto fossero più adatti i dirigibili che, nonostante la loro lentezza, offrivano una piattaforma stabile, comoda per l'equipaggio e con grande capacità di carico.
2.4 IL DIRIGIBILE ZEPPELIN
Il 6 Agosto del 1914 i tedeschi utilizzarono gli Zeppelin ZVI per colpire la citta belga di Liegi.
Non disponevano di bombe, ma esplosero otto granate d'artiglieria sulle quali avevano inserito, in maniera artigianale, delle alette realizzate in tessuto molto resistente. I risultati furono disastrosi. I belgi fecero un tale sbarramento antiaereo che gli Zeppelin ZVI colpiti da tutte le parti persero il gas e terminarono il loro volo precipitando.
I tentativi francesi con gli Zeppelin non ebbero miglior sorte: tre di loro vennero abbattuti addirittura dal "fuoco amico" della propria fanteria, due da colpi di cannone e il terzi dalle granate. Alla luce di questi eventi l'attività aeronautica da quel momento in poi si concentrò sugli aerei.
2.5
I PRIMI BOMBARDIERI
Il primo bombardamento aereo degno di questo nome della Prima Guerra Mondiale fu effettuato dagli inglesi. L'8 Ottobre del 1914 il Luogotenente Matrix, al comando di un Sopwith Tabloid (un biplano monomotore che in origine era conosciuto come aereo da corsa) attaccò una base di Zeppelin a Dussendorf, in Germania. L'aereo portava le bombe sulla fusoliera e il pilota disponeva di un sistema di sganciamento azionabile dalla cabina di pilotaggio.
Eseguendo una leggera picchiata verso l'hangar tedesco, Matrix riuscì a colpire un dirigibile che in una frazione di secondo si trasformò in una gigantesca torcia.
Questo piccolo aereo fu il precursore dei bombardieri.
Se gli inglesi furono protagonisti della prima azione di combattimento della guerra, dal canto loro i francesi furono i primi a concepire un vero e proprio bombardiere, il Voisin, un biplano dotato di un potente motore situato nella parte posteriore della fusoliera, capace di trasportare fino a 60 kg di bombe.
L'aviazione francese organizzò i Voisin in squadre di combattimento nel Settembre del 1914. Nel Maggio dell'anno successivo erano in attività già 600 unità di questo tipo.
Con il prosieguo del conflitto i principali inconvenienti tecnici dei primi aeroplani andarono via via scomparendo. Vennero aggiunti, anche se ancora rudimentali, i primi visori di puntamento, i motori diventarono sempre più potenti e comparvero anche i primi bombardieri dotati di più motori.
Uno dei nuovi modelli fu il russo Ilya Muromets, il primo biplano quadrimotore armato con quattro mitragliatrici. Questo aereo poteva restare in volo sino a cinque ore a un'altitudine di circa 3.000 metri e a una velocità di circa 137 km/h. Il suo carico era di circa 350 Kg di bombe.
Alla fine della Prima Guerra Mondiale i tedeschi erano già in grado di costruire aerei che avevano lìautonomia e la capacità di carico sufficienti ad attaccare il nemico sul proprio territorio anche lontano dal fronte.
Il più famoso dei bombardieri tedeschi fu il Gotha. Le ultime serie di questo modella, i Gotha GIII e GV, trasportavano 500 Kg di bombe ed erano in grado di colpire una città lontana come Londra. Infatti, il 13 Giugno del 1917 incominciarono i bombardamenti sulla capitale inglese che proseguirono fino a Maggio dell'anno successivo. L'impatto sui londinesi fu terribile. Venti anni più tardi il ricordo dei Gotha che avevano bombardato Londra era ancora vivo e questo lasciò un segno profondo nelle relazioni diplomatiche dei due Paesi.
[...]

















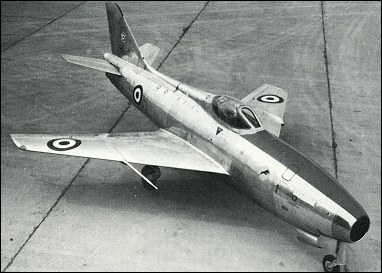














durante la seconda guerra mondiale un motore aereonautico finì per motorizzare anche l' M4 sherman, carro medio dell' esercito USA, il motore era il Wright-Continental R-975 Whilwind.




